OLIVETTI. UNA COMPLESSITA’ VIRTUOSA
Un nuovo libro edito dalla Università di Firenze sulla attualità del paradigma Olivetti.

Lo studio, la celebrazione, l’esercizio della memoria, le riflessioni sulla figura di Adriano, sulla sua Olivetti come modello di impresa, continuano a produrre saggi, articoli, libri , film, convegni , tesi di laurea.
A stimolarne la produzione preme un fortissimo sotterraneo giacimento culturale ancora inesplorato che con il suo patrimonio di idee fa emergere e sviluppare ricerche sulla funzione di sollecitazione culturale che la Olivetti ha avuto in Italia e nel mondo fino al suo declino e la sua scomparsa, il tutto in un processo continuo di elaborazione di verità e di storia che va oltre la coltivazione della mitologia olivettiana.
Si tratta di un grosso processo di elaborazione della memoria e soprattutto della cultura d’impresa della Olivetti.
Da questo profondo giacimento culturale che rappresenta un grande patrimonio non solo per la memoria degli olivettiani, ma d’interesse pubblico per la elaborazione della storia industriale del Paese, emerge la pubblicazione per le edizioni Firenze University Press del libro Olivetti. Una complessità virtuosa a cura di Lorenzo Capineri, docente di quell’Ateneo, con la prefazione del Cardinale Matteo Zuppi, Vescovo di Bologna e Presidente della CEI e scritti di Paolo Rebaudengo, Galileo Dallolio, Lauro Mattalucci (ex dipendenti della Olivetti), Mario Piccinini (architetto e urbanista), Erica Rizziato (ricercatrice al CNR di Roma e docente all’Università Pontificia Antonianum), Lorenzo Capineri, Antonio Chini, Carlo Odoardi e Nicola Cangialosi, docenti dell’Ateneo fiorentino.
Studiare la storia della Olivetti era e resta difficile. scrive Alberto Saibene in L’Italia di Adriano Olivetti: significa infatti mettere insieme design, organizzazione industriale, architettura, strategia di comunicazione, prospettive politiche, ruolo degli intellettuali, valori etici, coscienza sociale, l’uso delle esperienze artistiche, ricerca tecnologica, grafica ed il fine ultimo della comunità.
A dominare ed a rendere più complesso il quadro della cultura d’impresa di questa società emerge la figura di Adriano Olivetti, imprenditore, intellettuale, editore, politico, figura chiave dello sviluppo industriale italiano nella prima metà del novecento, poliedrico e visionario, audace innovatore nella creazione di una comunità concreta di lavoro, di intelligenze, produttrice di ricchezza non solo materiale e non solo per gli azionisti.
Esaminare questo poliedrico quadro, studiarlo nella sua interezza per ricavarne un paradigma che abbia un valore di esempio e di sollecitazione per applicazioni nella realtà attuale resta un compito estremamente difficile che ancora non è stato affrontato nella sua compiutezza.
Per adempiere a questo compito si misurano gli autori del libro con competenza e passione: da una parte gli olivettiani sulla base della propria esperienza e memoria ma con grande capacità di elaborare la loro testimonianza con studio e ricerca approfondita, dall’altra parte gli accademici con riflessioni e visioni sulla feconda relazione tra il paradigma olivettiano e le ricadute provocative sulla innovazione dei processi educativi.
Ne risulta un quadro di analisi di una parte cospicua della cultura d’impresa della Olivetti di Adriano.
Lo studio si sviluppa partendo dall’analisi del pensiero spirituale di Adriano, pensiero e lezione che costituiscono l’impronta etica della costruzione della comunità concreta della sua impresa (Rebaudengo) e continua, con grande ricchezza di contenuti originali, trattando l’evoluzione di quella società nel passaggio tumultuoso dalla meccanica all’elettronica con particolare riferimento ai processi distintivi dello sviluppo della cultura mercatistica spesso in antitesi con la cultura della fabbrica ( Dallolio ). Al profondo rinnovamento degli obiettivi e dei metodi produttivi della fabbrica si associa un processo di innovazioni architettoniche che produrrà negli anni la “nuova architettura olivettiana”. Piccinini sviluppa questo tema con particolare riferimento all’attenzione di Adriano ai problemi del mezzogiorno con l’intervento concreto della costruzione della fabbrica a Pozzuoli. Rizziato, riprendendo la lezione di Franco Novara, maestro olivettiano di psicologia del lavoro, ne sviluppa il pensiero in una prospettiva progettuale sulla connessione tra lo sviluppo personale e quello della organizzazione indicando concrete ipotesi di processi educativi per la formazione del “manager orizzontale” di stampo olivettiano.
Il classico tema nella ricomposizione della cultura tecnico scientifica e quella umanistica viene ripreso e sviluppato da Mattalucci alla luce delle esperienze olivettiane, con felici riferimenti iconici alla cultura d’immagine della Olivetti.
Capineri e Chini, dal coté accademico, trattano con competenza e profondità l’ipotesi della utilizzazione del paradigma Olivetti nei processi di formazione del nuovo ingegnere. “La formazione attuale dell’ingegnere è concepita per ruoli diversi: non solo di progettista ma di esecutore, gestore della sicurezza e analista economico. Inoltre, oggi, l’ingegnere copre ruoli strategici ed è sempre più richiesto l’allargamento della formazione verso una cultura generale.
È necessario ripensare e riprogettare le diverse specializzazioni dell’ingegnere attraverso una formazione multidimensionale e multidisciplinare. Ruolo essenziale per approfondire le conoscenze specialistiche diventa l’interazione tra docenti di diverse discipline al fine di offrire allo studente una visione interdisciplinare anche grazie all’utilizzazione di strumenti didattici digitali.
Odoardi e Cangialosi, anch’essi dell’area universitaria, traggono dalla lezione di Adriano la rilevanza della leadership capace di valorizzare l’impegno, la responsabilità e lo spirito di iniziativa del gruppo dove si confrontano le conoscenze e le diverse competenze tra operai, tecnici, dirigenti: leadership e innovazione, due le parole chiave nella visione del lavoro nella Olivetti di Adriano.
Nella attività formativa e lavorativa alla Olivetti di Adriano si promuovono comportamenti di una corretta competizione, da cum petere, dice Odoardi, che non significa antagonismo, significa andare insieme verso un obiettivo comune. In conclusione si propone l’obiettivo comune di progettare l’insegnamento delle materie STEM in modo da preparare i discenti ad affrontare la complessità introducendo elementi di cultura umanistica nei percorsi di alta formazione.
Il mondo dell’accademia è debitore della cultura olivettiana che ha costituito un grande affluente nel mainstream universitario. Molti sono stati i dirigenti Olivetti che sono passati all’insegnamento con una contaminazione feconda di esperienze e di studi, portando con loro la ricchezza dell’esperienza di lavoro alla Olivetti come professione dell’intellettuale secondo la lezione di Max Weber. (Aldo Carotenuto, Alberto Spreafico, Antonio Carbonaro, Alessandro Pizzorno, Luciano Gallino, Franco Novara, Federico Butera……).
Ritengo che questo libro “Olivetti, una complessità virtuosa” (meglio forse “armoniosa”), possa rappresentare la continuazione di quella feconda tradizione e possa costituire per la sua originalità un reale arricchimento culturale per l’università, soprattutto per la funzione di sollecitazione al ripensamento degli insegnamenti meramente tecnici.
È per questa ragione che il libro può costituire riferimento per un reale processo di contaminazione culturale tra l’area tecnica e le discipline umanistiche per l’ampliamento e l’arricchimento delle competenze professionali necessarie al neolaureato per affrontare le nuove sfide che i cambiamenti tumultuosi ormai impongono in termini ultimativi.
In conclusione libro è certamente un testo non esaustivo dell’intera cultura d’impresa dell’Olivetti, ma per questo rappresenta un testo seminale, un incentivo a continuare studi e ricerche per definire e completare l’intero perimetro di quella cultura e la possibile applicazione della utopia concreta di Adriano Olivetti. Della quale in questo momento il nostro paese ha grande bisogno.
È questo l’augurio del cardinale Zuppi nella sua magistrale prefazione:
Ecco, il nostro passato ma decisamente il futuro che vorremmo.
…Habent sua fata libelli.
Fiesole, 12 febbraio 2025

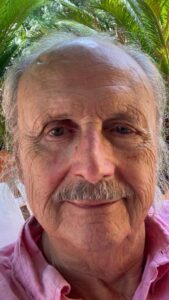
La mia esperienza di quadro in Olivetti Systems and Networks, dal 1983 al 1989, non è ancora comunicabile.
Posso solo continuare a tentare strade nuove, come https://mastodon.uno/@casarayuela/114015472916150731, dove cito questo articolo, in un “thread” avviato dall’iniziativa “parents4future” fasendo uso di una piattaforma sociale “open source”, senza ottenere riscontri. Come succede sempre.
Ho scritto innumerevoli commenti in risposta ad articoli giornalistici.
So benissimo che i giornalisti, su ciò che scrivono i lettori, si limitano a praticare il lurking :-((
quindi è inutile insistere a tentare.
Vorrei tanto poter leggere cosa significa disporre di un telefono “smart” che ogni tanto aggiorna un sistema operativo che si chiama ONE UI [un’unica interfaccia utente – quella “algoritmica”].
Vorrei che fosse noto a tutti che i sistemi operativi algoritmici iniziarono ad evolvere grazie all’esistenza di un’interfaccia umana.
Vorrei poter leggere, in tempo utile a prevenirne le conseguenze, che con quel tipo di sistema “algoritmico”, tra non molto, anche gli occhiali saranno abbastanza “smart” da sostituire il telefono.
Vorrei poter leggere che un sistema “operativo” – per non finirne gestito e controllato come se io stesso fossi un dispositivo di input/output – dovrebbe essere “generato” da un processo di “governance sociale”, basato sulla interconnessione e l’interoperabilità di “comunità” … ciascuna delle quali composta da persone che condividono un “intento utente” primario.
Comunità e Intenzionalità sono le parole che mi aspettavo sarebbero state comprese dalla direzione del personale della Olivetti Systems and Networks, nel 1983.
Lo sapevo perché avevo alle spalle 15 anni di esperienza in tre diversi esempi di ambienti “comunitari” di gestione del digitale.
Ma non avevo alle spalle università e giornalismo.
L’odierna arroganza delle big tech nord-americane nasce dall’ignoranza dell’esperienza europea nella “gestione comunitaria” di sistemi informatici.
Il Web è stato generato da quel tipo di esperienza!
Della “intenzionalità della OSN”, a inizio anni 80, venni a sapere leggendo il Sunday Times in Inghilterra, dove mi trovavo come funzionario internazionale dell’ECMWF [European Center for Medium Range Weather Forecast].
L’annuncio che l’Olivetti si stava preparando ad essere “leader” dei “sistemi aperti” attirò la mia attenzione – di “analista di sistema” in “ambienti di gestione di sistemi informatici” – per due motivi professionali:
1)
i due concetti, di “leader” e di “sistema aperto”, sono incompatibili;
2)
il concetto di “apertura” di un sistema lo avevo “assimilato” lavorando nella Data Handling Divison del CERN, nel 1969, per la mia tesi di laurea in Fisica; associavo quindi la qualità di “apertura” del sistema al suo “ambiente di gestione di una relazione asimmetrica” – tra utente e informatica – che, per poter essere “paritaria”, richiedeva l’esistenza di un “ruolo di aiuto”, reso disponibile come “aspetto organizzativo” di un tipo di ambiente, come quello del CERN, primariamente “comunitario”, in modo diverso da quello delle mie esperienze in ECMWF e CINECA .
……
Questa “condizione iniziale del moto” – per la mia esperienza di quadro in OSN – richiederebbe un approfondimento … se si volesse capire come mai la traiettoria del mio percorso di vita professionale abbia fallito il bersaglio della “intenzionalità europea” di creare una rete informatica distribuita, per le Pubbliche Amministrazioni degli Stati Membri, ispirata da un modello di riferimento “implementativo” noto con il nome di Open Systems Interconnection [OSI].