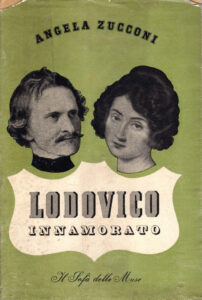Angela Zucconi, la donna che ha fatto dell’utopia un metodo (*)
di Adele Rugini
Nell’estate 2000 viene pubblicato, per i tipi dell’Ancora del Mediterraneo, l’autobiografia di Angela Zucconi, Cinquant’anni nell’utopia. Il resto nell’aldilà, che Goffredo Fofi definisce uno dei libri di memorie “più belli che la letteratura italiana del Novecento possa vantare”. Pochi mesi dopo, il 17 novembre, Zucconi muore ad Anguillara Sabazia a 86 anni.
Tra le ultime pagine della sua autobiografia, Zucconi scrive: “Arrivata all’ultimo tornante della spirale, la sola certezza che ho: siamo nati per crescere dalle nostre radici e dobbiamo fare di tutto per continuare a crescere fino alla fine”. La spirale di cui parla è quella di una vita radicata nelle idee ancor prima che nei luoghi, una forma aperta, eternamente in divenire, fatta di incontri, relazioni, immaginazione e azioni condivise. Una vita che è stata anche presenza fondamentale nell’orizzonte intellettuale (troppo spesso pensato come eminentemente maschile) che ha contribuito alla costruzione e alla critica sempre vigile della nostra democrazia.
Nata a Terni, quando ha quattro anni Zucconi si trasferisce con la famiglia a Bengasi perché il padre viene nominato procuratore del re in Libia. Dopo dieci anni rientra in Italia, prima a Trieste, dove avvia gli studi ginnasiali e si appassiona allo studio della lingua e della cultura tedesca, dando vita a quel “rapporto tra mondo germanico e mondo latino” che sarà un “filo sempre presente” nella sua vita. Successivamente, nel 1930, sempre seguendo la carriera paterna, Zucconi si sposta a Roma, dove prosegue gli studi presso il Liceo Mamiani.
Esperienze giovanili e l’incontro con Adriano Olivetti
In quegli anni, inizia a frequentare l’eremo umbro di Campello sul Clitunno, dove entra in contatto con una comunità di suore francescane guidate da sorella Maria (Valeria Pignetti), che è in corrispondenza epistolare con Gandhi, Albert Schweitzer, Paul Sabatier e che ospita anche figure scomode come Primo Mazzolari ed Ernesto Buonaiuti (due celebri preti antifascisti). All’eremo Zucconi conosce Barbara Allason, scrittrice e germanista, con cui condivide la passione per la cultura tedesca (Allason cura le edizioni italiane di autori tra cui Nietzsche, Schiller e Goethe) e grazie alla quale si avvicina all’antifascismo di stampo crociano.
Nel 1933, appena diciannovenne, pubblica per l’editore Airoldi una raccolta di poesie, Viaggi senza approdo, e nel 1937 si laurea in germanistica presso la Facoltà di Lettere dell’Università “La Sapienza” di Roma, con una tesi su alcune lettere inedite della marchesa Marianna Florenzi Waddington, amante di Ludovico I di Baviera.
Dopo un periodo di ricerca a Copenaghen dedicato allo studio di alcuni inediti di Lodovico di Baviera conservati presso il museo Thorwaldsen, nel 1941 avviene un incontro che segnerà il suo percorso di vita, quello con Adriano Olivetti (dai più conosciuto come imprenditore, ma in realtà anche editore, urbanista e politico, da Zucconi definito “rivoluzionario”). Grazie all’amico comune Roberto (Bobi) Bazlen, Olivetti le affida per le Nuove Edizioni Ivrea (poi Edizioni di Comunità) la traduzione integrale delle opere di Søren Kierkegaard. Zucconi torna quindi in Danimarca per completare il lavoro e rientra stabilmente in Italia nel 1943, dove nel 1944 riesce a pubblicare per Rizzoli il testo che raccoglie le sue ricerche universitarie, dal titolo Lodovico innamorato.
Nello stesso anno integra l’insegnamento al liceo con un lavoro pomeridiano come editor delle traduzioni presso la sede romana di Einaudi, dove conosce Cesare Pavese, Felice Balbo, Franco Rodano, ma soprattutto Natalia Ginzburg. Giovane vedova di Leone, all’epoca nella redazione della casa editrice, Ginzburg diventa una sua carissima amica e rievoca l’amicizia con Zucconi nel breve racconto Le scarpe rotte, scritto nell’autunno del 1945 e pubblicato nel 1962 nella raccolta Le piccole virtù. Ginzburg parla così di Zucconi:
“La mia amica ha un viso pallido e maschio, e fuma in un bocchino nero. Quando la vidi per la prima volta, seduta a un tavolo, con gli occhiali cerchiati di tartaruga e il suo viso misterioso e sdegnoso, col bocchino nero fra i denti, pensai che pareva un generale cinese. Allora non lo sapevo che aveva le scarpe rotte. Lo seppi più tardi. Noi ci conosciamo soltanto da pochi mesi, ma è come se fossero tanti anni. La mia amica non ha figli, io invece ho dei figli e per lei questo è strano. Non li ha mai veduti se non in fotografia, perché stanno in provincia con mia madre, e anche questo fra noi è stranissimo, che lei non abbia mai veduto i miei figli. In un certo senso lei non ha problemi, può cedere alla tentazione di buttar la vita ai cani, io invece non posso. I miei figli […] come saranno da uomini? Voglio dire: che scarpe avranno da uomini? Quale via sceglieranno per i loro passi? Decideranno di escludere dai loro desideri tutto quel che è piacevole ma non necessario, o affermeranno che ogni cosa è necessaria e che l’uomo ha il diritto di avere ai piedi delle scarpe solide e sane?
Con la mia amica discorriamo a lungo di questo, e di come sarà il mondo allora, quando io sarò una vecchia scrittrice famosa, e lei girerà per il mondo con uno zaino in spalla, come un vecchio generale cinese, e i miei figli andranno per la loro strada, con le scarpe sane e solide ai piedi e il passo fermo di chi non rinunzia, o con le scarpe rotte e il passo largo e indolente di chi sa quello che non è necessario”.
Il periodo romano. Il tema della partecipazione dei cittadini e dell’assistenza sociale
Ginzburg si trasferisce a vivere con Zucconi nella casa di famiglia di via Cola di Rienzo 212, a Roma, anche se sa che la loro convivenza sarà breve: “La nostra vita comune durerà poco, presto io partirò e tornerò da mia madre e dai miei figli, in una casa dove non mi sarà permesso di portare le scarpe rotte”. Durante il loro tempo insieme progettano la pubblicazione di una rivista bimestrale dal titolo «Arianna». Pensato come spazio educativo con cui contribuire alla ricostruzione del Paese con nuove proposte, avrebbe voluto essere, ricorda Zucconi, “un modo di agire più che un’occasione di scrivere”, un luogo di testimonianze, perché “nel fervore di quei mesi in fondo credevamo che bastasse far uscire dall’ombra la donna perché l’utopia di oggi diventasse la politica di domani”. Ma la rivista, per diverse ragioni tra cui gli interessi divergenti delle due amiche, non uscirà mai.
A partire dalle riflessioni avute durante gli anni della guerra, Zucconi matura una profonda coscienza politica di orientamento democratico e socialista e, animata da un altrettanto forte “ottimismo della volontà”, decide di lasciare il lavoro intellettuale da Einaudi e aderire nel 1945 (insieme a Giuliana Benzoni, Ada Gobetti, Ebe Flamini, Ignazio Silone, Augusto Frassineti, Giorgio Manganelli, Giuseppe Dessì e altri) al comitato promotore del Movimento di Collaborazione Civica (MCC). Movimento che nasce a Roma per favorire maggiore partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini alla vita democratica e che è attento all’educazione delle fasce più giovani della popolazione. Zucconi, per la quale il MCC rappresenta il primo “totale cambiamento di vita”, si impegna nel reclutamento e nella formazione di volontari nei licei di Roma per organizzare, tra il 1946 e il 1947, le prime colonie estive e i primi doposcuola nei quartieri popolari della capitale, insieme a un soggiorno di tre mesi in Danimarca per mille bambini romani.
Nel 1946, dopo l’iscrizione all’UDI (Unione Donne Italiane), partecipa come delegata del MCC al Convegno per studi di assistenza sociale di Tremezzo sul lago di Como, momento cruciale nella definizione di un sistema di welfare italiano, che trae ispirazione anche dal piano Beveridge inglese. Elaborato alla fine del 1942, il piano Beveridge è comunemente considerato il documento fondativo del moderno Welfare State, che accanto al riconoscimento e alla tutela dei tradizionali diritti civili e politici propri dello Stato liberal-democratico, introduce una garanzia sistematica di diritti sociali fondamentali, tra cui il diritto al sostentamento e il diritto al lavoro.
Al convegno di Tremezzo le tre principali tradizioni dell’assistenza italiana (cattolica, fascista e laico-azionista) si confrontano sui nodi centrali della ricostruzione post-bellica: emergenza abitativa, indennizzi ai civili, trattamento previdenziale dei partigiani, sviluppo delle case popolari, gestione dei campi profughi, politiche di emigrazione e immigrazione, orientamento scolastico e professionale, tutela della salute mentale e organizzazione di nuovi servizi sociali.
La speranza dei partecipanti è quella di concepire un sistema di assistenza che possa superare il centralismo e il paternalismo fascisti, ma Zucconi ne esce amareggiata: “il convegno era nettamente diviso fra chi voleva e chi non voleva le riforme e l’istituzione di servizi sociali. Prevalsero i secondi. […] l’utopia non diventò la politica di domani. Prevalse la politica assistenziale demagogica del giorno dopo giorno, di cui tuttora paghiamo i debiti”.
È qui che l’intellettuale matura la convinzione che, senza formazione all’assistenza sociale né pianificazione urbanistica lungimirante, lo sviluppo materiale e civico del Paese non sarebbe stato possibile, perché condannato all’assistenzialismo. Decide quindi di impegnarsi all’interno del Centro di educazione professionale per assistenti sociali (Cepas) fondato da Guido Calogero e Maria Comandini Calogero, e che Zucconi dirige dal 1949 al 1963.
La questione meridionale
Adriano Olivetti, che ne è generoso finanziatore, in qualità di membro della Prima Giunta dell’UNRRA-Casas (l’ente parastatale creato nel 1947 per impiegare in Italia i fondi di soccorso americani destinati ai senza tetto) e di presidente dell’INU (Istituto Nazionale dell’Urbanistica), nel 1953 coinvolge il Cepas di Zucconi nel progetto di costruzione del borgo comunitario “La Martella” a Matera. In quegli anni la città lucana rappresenta il simbolo politico della questione meridionale, dopo che Carlo Levi, nel suo romanzo autobiografico Cristo si è fermato a Eboli, denuncia le condizioni di arretratezza dei cosiddetti “Sassi”, grovigli di case sovraffollate prive delle elementari condizioni sanitarie per vivere con dignità: “Dentro quei buchi neri dalle pareti di terra vedevo i letti, le misere suppellettili, i cenci stesi. Sul pavimento erano sdraiati i cani, le pecore, le capre, i maiali. Ogni famiglia ha in genere una sola di quelle grotte per abitazione e ci dormono tutti insieme, uomini, donne, bambini, bestie”.
Olivetti, colpito da quella che nel 1948 Palmiro Togliatti definisce una “vergogna nazionale”, decide di costituire una “Commissione per lo studio della città e dell’agro di Matera”, composto da un gruppo di intellettuali presieduto dallo stesso Olivetti e dal sociologo Friedrich G. Friedmann, con esperti di geografia (Giuseppe Isnardi), storia (Francesco Saverio Nitti), etnologia, paleoetnologia (Eleonora Bracco), urbanistica-architettura (Federico Gorio e Ludovico Quaroni), demografia, psicologia, economia e, con Zucconi, assistenza sociale. Lo scopo della commissione è quello di avviare un’indagine per conoscere a fondo le condizioni di vita degli abitanti dei Sassi e, successivamente, proporre soluzioni per trasferirli in quartieri nuovi. Una cosa è chiara al gruppo: la progettazione dei nuovi complessi abitativi deve tener conto della vita e della cultura dei materani, fatta di solidarietà tra famiglie dello stesso vicinato. Il borgo “La Martella”, che cerca di riprodurre le stesse condizioni di coesione sociale presenti nei rioni in tufo secondo il principio urbanistico della neighborhood unit, si configura come una critica implicita allo sviluppo moderno: rivela infatti che la modernità non può essere un paradigma universalmente trasferibile, ma un processo che deve confrontarsi con la storia di una popolazione fatta di tempi e culture diverse.
Il progetto materano, che secondo Zucconi testimonia “un concreto intervento di trasformazione” nutrito da “una visione ammirata e sofferta di questi paesi in cui la miseria delle condizioni di vita si accompagnava a quell’altissimo senso di dignità, con cui la civiltà contadina si presentava e di cui era fiera e gelosa”, è purtroppo destinato a rimanere incompleto a causa dell’ostruzionismo della classe dirigente di quegli anni.
Per questa ragione, nel 1955, Zucconi lascia la direzione del Cepas a Paolo Volponi e accetta l’offerta di una borsa di studio Unesco per un lungo viaggio di studio in Messico, per visitare le diverse missioni culturali del Paese. A Pátzcuaro incontra Florita Botts, fotografa californiana ed esperta di educazione degli adulti, con cui instaura un sodalizio che durerà per tutta la vita. Insieme si recano in Portorico nel 1956, dove scoprono la metodologia della Divisione per l’Educazione della Comunità (DivEdCo) portoricana, l’agenzia governativa incaricata di educare le comunità rurali dell’isola caraibica alla partecipazione democratica.
Rientrate in Italia nella primavera del 1956, Botts e Zucconi (che nel frattempo riprende le redini del Cepas), intendono reinterpretare il modello portoricano (integrazione tra attività culturali-educative rivolte alla maturazione civica e democratica delle comunità, e iniziative di stimolo allo sviluppo economico delle aree rurali e delle economie depresse) per avviare un “Progetto Pilota” in Abruzzo.
Elaborato insieme a Olivetti, il Progetto Pilota, che per Zucconi è un’occasione “per riprendere il discorso rimasto interrotto alla Martella”, prende avvio nel 1958 coinvolgendo quattordici comuni montani delle province dell’Aquila e di Chieti.
Si tratta di un processo faticoso che, contrariamente a quanto uno sguardo orientato da pregiudizi romantici si aspetterebbe dai piccoli comuni rurali, richiede lo sforzo di superare l’isolamento, la mancanza di partecipazione e le abitudini scarsamente cooperative degli abitanti. Per questo Zucconi si trova a dover immaginare modalità di ristrutturazione di modelli partecipativi in virtù di un nuovo senso di appartenenza così da favorire cooperazione e solidarietà. E questo senza imporre sé stessa e il gruppo di assistenti sociali come intelligenze superiori pronte a sostituirsi all’iniziativa della gente, indicando la propria interpretazione dei problemi e, allo stesso tempo, le proprie soluzioni.
Fondamentale, evidentemente, è il rispetto del diritto di autodeterminazione della comunità, senza il quale si cadrebbe nel paternalismo di una “ricreazione organizzata”. In un famoso articolo del 1951 dal titolo Ricreazione educazione e servizio sociale, Zucconi ricorda infatti che “un’educazione popolare che non creda alla cultura per il popolo, ma che tenga tra l’altro conto della cultura del popolo, […] che miri non a servire la politica ma piuttosto a servirsene, si propone anzitutto uno sviluppo della consapevolezza individuale (conoscenza di sé, della società e del tempo in cui viviamo, dei rapporti sociali, del potere che hanno le influenze reciproche, ecc.), mira a un processo di oggettivazione dei problemi individuali (in rapporto quindi con certe forme di psicoterapia collettiva) e infine a un allargamento progressivo dell’orizzonte in senso sociale e storico. Del resto ogni educazione che non miri a fare degli stiliti è di necessità sociale”.
Di fallimenti e di opportunità per la società civile e la comunità
Anche il Progetto Pilota incontra però una fine nel 1962, soprattutto a causa della scomparsa di Olivetti, il suo più grande sostenitore economico. E, con la sua morte, ricorda Zucconi, scompare anche “la speranza e l’immaginazione di un’Italia della società civile che non fosse soggetta ai partiti-padroni. I progetti di sviluppo comunitario […] rappresentavano le risposte nuove e concrete di cui il nostro Paese aveva bisogno: era necessario identificare e valorizzare la comunità, anche quella dissepolta dalle macerie della guerra, perché è il seme della coesione civile, la radice che consente la crescita”.
Quell’Italia della società civile che rimpiange Zucconi è frutto della cultura progettuale che attraversa numerosi laboratori utopici tra gli anni Quaranta e Sessanta (si pensi a Danilo Dolci in Sicilia e ad Aldo Capitini in Umbria). Una cultura che, rivisitando criticamente una certa modernità, ne rigetta l’impostazione verticale (il modello di un singolo soggetto o di un gruppo ristretto che elabora un progetto da imporre al gusto delle masse) e sperimenta, invece, un metodo utopico in cui il mondo precede il soggetto: chi progetta (e dunque critica e intende modificare un ambiente umano) si inserisce in una realtà già data e ne asseconda le logiche, in primo luogo quelle della natura e della pluralità di voci (e di immaginari) che la abitano.
La fine apparente di questa cultura e dei suoi laboratori non costituisce un “fallimento”, ma un’opportunità per il presente: solo un’opera incompiuta può farsi potenzialmente infinita, offrendo fessure, interstizi e varchi suscettibili di continui riattraversamenti. Il repertorio di possibilità del passato si rivolge sempre all’immaginazione presente, affinché possa attingere, attraverso le crepe di questa imperfezione, all’orizzonte di progetti che fanno della comunità il fine necessario per la costruzione di un tessuto socialmente vivo.
Per questo Zucconi rappresenta un pensiero cui vale la pena tornare. Non soltanto per coltivare la memoria di un personaggio ancora troppo poco conosciuto; ma soprattutto per ricavare strumenti di intervento convincenti e produttivi per l’oggi. Infatti, come osserva Goffredo Fofi, “con il suo rigore morale, la sua chiarezza intellettuale, la sua intelligenza pratica del “che fare”, la sua insistenza sull’aiutare gli altri “perché si aiutino da soli”, Angela Zucconi ha molto da dire ai lettori che non si accontentano di consumare […] un pensiero altrui, un’esperienza altrui, ma sentono ancora il bisogno di strapparne indicazioni utili al loro agire quotidiano e al senso da dare alle proprie scelte, alla propria vita”.
Una vita che, come tutte le altre, ha bisogno di crescere dalle proprie radici e di nutrirsi di utopie.
Intellettuale, attivista, poeta e traduttrice: Angela Zucconi è stata questo e molto altro. Dal dopoguerra in poi, Zucconi ha, in particolare, saputo indicare una via in grado di coniugare cultura e intervento diretto sulla realtà che vale ancora la pena percorrere oggi.
(*) Questo articolo è apparso per la prima volta su “Le vite degli altri”, newsletter mensile della rivista on line Lucy-Sulla cultura, 11 gennaio 2026. Viene qui riprodotto per gentile concessione senza la galleria fotografica che lo correda visibile al link originale dell’articolo
https://9q1yc.r.sp1-brevo.net/mk/mr/sh/1t6AVsd2XFnIG8W9AH4Fr81miy4R0f/Wy4I7TNigrXw
Maggiori informazioni sulla rivista e sulla newsletter nel sito https://lucysullacultura.com/ e in particolare nella sezione “Chi siamo” https://lucysullacultura.com/chi-siamo/